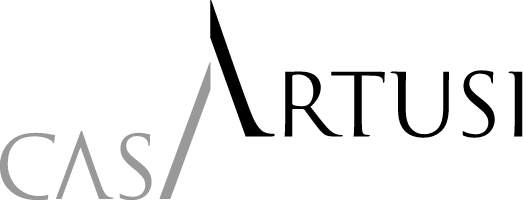Bologna in tavola. Un’identità plurale
- Data
L’ultimo libro di Massimo Montanari (Bologna, l’Italia in tavola, Il Mulino, 2021) propone un tema che va al di là dello specifico gastronomico. Che cosa, di una città, di un territorio, si può definire identitario?
La chiusura feticistica e autoreferenziale in un proprio status immaginario, incrollabile e immodificabile. Oppure l’apertura all’incontro, al confronto con altri mondi, altre realtà, altre culture. Montanari non ha dubbi in proposito, e Bologna ne rappresenta l’esempio più eclatante: è la città che più di altre, in Italia, ha l’attitudine ad accogliere e armonizzare una pluralità di suggestioni provenienti dall’altrove che, messe a confronto con la tradizione locale, vanno a determinare quello che possiamo definire il Genius Loci.
Un’identità che va declinata, dunque, al plurale, e non al singolare. È la cosiddetta “Bologna grassa”, che vede, fin dal Medioevo, la sua cultura dell’ospitalità interagire sia in campo gastronomico che nell’ambito degli studi universitari. “Grassa”, nel senso di ricca e opulenta in un mondo attraversato periodicamente dalla paura della fame. E, allo steso tempo, “Dotta”, per la presenza dello Studio, il più antico e apprezzato d’Europa. Durante la signoria di Giovanni II Bentivoglio, il valore del cibo nella costruzione dell’immagine della città diviene addirittura un “progetto politico”, come dimostra il ciclo di affreschi realizzato, fra il 1475 e il 1481, nel castello di Bentivoglio, dove viene raffigurata la sequenza completa della produzione del pane, dalla semina al raccolto, fino alla trebbiatura, all’impasto e alla cottura. In simbiosi con la città, peraltro, vive da sempre una diffusa comunità di studenti e professori stranieri, con i propri gusti e stili di vita. Nel 1553 sono presenti a Bologna 46 gruppi nazionali, fra cui, il più consistente, è decisamente quello teutonico. E non è un caso che nel XV secolo, fra le principali osterie della città, ne esistessero almeno due gestite da tedeschi, come quelle della Luna e dell’Agnello.
Ora, in questo quadro in cui sapori e studi si intersecano fortemente, qualcosa deve pur succedere. Certo, Montanari allarga giustamente il suo sguardo sulle verdure e i frutti provenienti dalle vicine campagne, sui pesci da consumare nei giorni di magro, sulle varie tipologie di pasta fresca. Ma poi il discorso va a cadere inevitabilmente sul divino maiale, sui salumi che se ne ricavano e, in particolare, sul prodotto identitario per eccellenza: la mortadella. Non è un caso che Giuseppe Maria Mitelli, nel suo Gioco della Cuccagna (del 1691), individui proprio nella mortadella di Bologna la casella che vince l’intera posta. Ed è proprio su questo tema che il libro offre un chiarimento definitivo. A partire dall’etimologia, che deriva certamente da mortarium, mortaio, cioè dallo strumento per pestare la carne, già individuato dal Susini in una stele romana dedicata a un allevatore di maiali.
Ma cos’è che ne determina il trionfo, tanto da farne un “cibo da re”, distinguendola dai tanti confratelli e consorelle di provenienza suina. Sono la consistenza, il sapore e il colore, del tutto eccentrici rispetto a gran parte dei salumi di casa nostra, e magari vicini ai caratteri di alcuni prodotti d’oltralpe, in particolare a quelli di tradizione tedesca, come la grande famiglia dei würstel. Non si tratta, si badi bene, di lesa maestà, ma di uno straordinario caso di fusion culturale che ha generato un prodotto che si può definire identitario per antonomasia, al plurale e non al singolare: la mortadella di Bologna.
Giordano Conti, componente del Comitato Scientifico di Casa Artusi